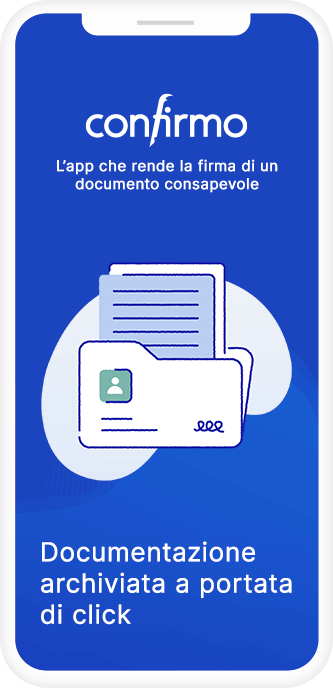Un grande problema: il paziente quanto comprende?
Non è affatto semplice per un medico riuscire a far comprendere quanto stabilito dalla normativa. Ogni paziente dimentica tra il 40% e l’80% delle informazioni fornite dal medico appena esce dall’ambulatorio, rendendo questo processo poco efficace.
Chi può dare il consenso informato?
Chiunque sia il diretto interessato di un atto medico, se maggiorenne, cosciente e capace, deve dare il proprio consenso al personale sanitario perché possa agire legittimamente.
Dato che si tratta di una manifestazione di volontà libera e consapevole, alcuni soggetti possono non essere nelle condizioni di soddisfare questi requisiti. Non si fa distinzione tra minorenni, interdetti e inabilitati, si parla generalmente di pazienti incapaci. Il paziente incapace “Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà”, come si legge nell’art. 3 comma 1 della legge 219 del 22 dicembre 2017.
Fermo restando quanto sopra, il consenso informato dal paziente incapace, sia esso interdetto o inabilitato, viene espresso dal tutore o dalla medesima persona inabilitata. Talvolta, da un amministratore di sostegno se la nomina prevede "l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario” (nell’art.3, comma 1, 219 del 2017). Le parti nominate nella procura per l’assistenza sanitaria hanno il titolo per operare nell’interesse della persona che rappresentano.
Quando serve il consenso informato?
Il consenso informato serve a rendere lecito un determinato atto sanitario. In assenza del quale si ricade nel reato.
E’ obbligatorio per il medico informare e acquisire il consenso del paziente prima della prestazione sanitaria. I tempi e le modalità devono permettere alla persona assistita di riflettere sulle informazioni ricevute, anche se esistono alcune eccezioni ben definite.
Non serve ottenere il consenso nelle situazioni di estrema urgenza che richiedono l’immediato intervento, ad esempio in condizioni che mettono a rischio di vita il paziente, perché si opera in ambito di "consenso presunto". Lo stesso vale quando si effettuano cure di routine, come ad esempio i prelievi ematici, in quanto si opera secondo “consenso implicito”.
La tutela dell’articolo 32 della Costituzione
L’articolo 32 della Costituzione italiana riguarda la tutela della salute, uno dei diritti fondamentali della persona.
Il termine salute indica certamente assenza di malattia, ma più ampiamente va inteso come uno stato di benessere psichico e fisico.
Tuttavia, lo stesso articolo specifica che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario. Lo scopo principale di questa precisazione è di vietare sperimentazioni senza l’esplicito consenso dei partecipanti.
Il rifiuto a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario è una scelta tutelata dalla Costituzione. Quindi, l’azione medica necessita di ottenere il consenso del paziente.
La legge 219/2017 va oltre promuovendo e valorizzando "la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico." (art. 1, comma 2).
L’articolo 32 mira anche a salvaguardare la salute della collettività. Per questo motivo il secondo comma si legge “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”. L’ultima parte della frase si riferisce ai trattamenti necessari per la tutela della salute pubblica, come ad esempio le vaccinazioni.
L’articolo si conclude con il divieto per la legge di superare i limiti del “rispetto per la persona umana”.